di Clelia Pallotta
Illustrazione di Doriano Solinas
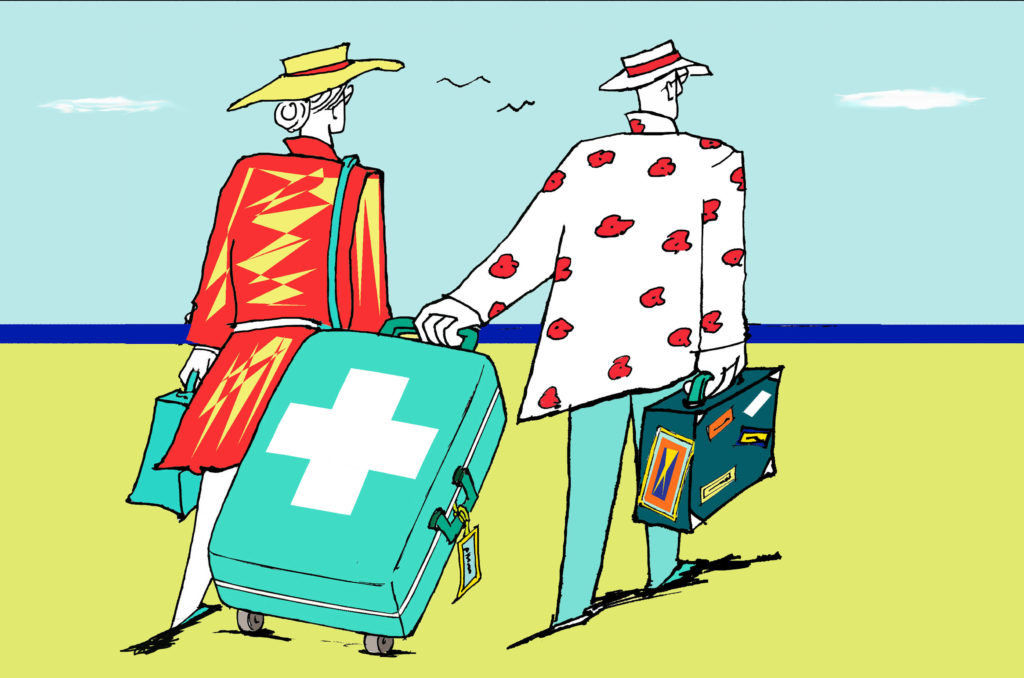
Partire dalla Sicilia a luglio, lasciando l’isola di Ortigia bianca in mezzo al blu intrecciato di mare e cielo, placida senza turisti e con pochi abitanti, per tornare a Milano, Lombardia, contagiata e minacciata più di ogni altro luogo della nazione, richiede uno sforzo di volontà. Dopo quattro mesi di esilio epidemico vissuto al sud quasi per caso bisogna tornare a casa: forse il riscaldamento è rimasto acceso, chissà se la macchina parcheggiata davanti al supermercato parte ancora, chissà le piante, chissà le amiche e i parenti, chissà, bisogna andare. Tutto quel tempo passato come acqua sotto un ponte sospeso, non ne posso più.
All’aeroporto di Catania ci accompagna la mia amica Rita per evitarci l’autobus e il rischio seppure remoto di contagio. Fa molto caldo sotto le mascherine dentro l’automobile in fila nel viale di accesso agli Arrivi da cui adesso si arriva e si parte per facilitare i controlli ed evitare confusioni e promiscuità. Un ordine magnifico, ci sono donne e uomini in divisa, con guanti, misuratori di temperatura, scanner portatili e mascherine, fermano le auto alla barra, mandano via gli accompagnatori, indirizzano alle entrate i viaggiatori che aspettano in fila di far controllare i biglietti e superare l’ultima barriera prima di avere il permesso di accedere all’aeroporto deserto. Tutti i negozi sono chiusi, un silenzio e un ordine mai visti a Catania, mi sento in Svizzera.
 Sull’aereo i posti sono alternati per mantenere la distanza, le cappelliere sono vuote, il bagaglio a mano è stato imbarcato in stiva per evitare contatti e assembramenti. La voce del comandante ci rassicura, va tutto bene, ci possiamo rilassare. Mi spruzzo il disinfettante sulle mani e mi addormento.
Sull’aereo i posti sono alternati per mantenere la distanza, le cappelliere sono vuote, il bagaglio a mano è stato imbarcato in stiva per evitare contatti e assembramenti. La voce del comandante ci rassicura, va tutto bene, ci possiamo rilassare. Mi spruzzo il disinfettante sulle mani e mi addormento.
Mi sveglio che stiamo per atterrare su Malpensa, buia e tempestosa sotto un temporale. Meno male, mi dico, che ci faranno scendere col finger come siamo saliti a Catania, ho letto che non si usano gli autobus per evitare contatti ravvicinati. Non mi sono mai piaciuti gli autobus che portano dall’aereo all’aeroporto, affollati, con pochi appigli, spesso guidati da autisti spericolati che sballottano tutti di qua e di là. Invece ci fermiamo lontano da tutto, in aperta campagna e fuori ci sono due autobus. Niente finger. Niente controlli, neanche al recupero bagagli, sono le dieci di sera e in giro ci sono solo viaggiatori, nessun addetto dell’aeroporto, nessun rappresentante delle forze dell’ordine. Nessun misuratore di temperatura, nessuna verifica di documenti, nessuna indicazione. Aspettiamo tre quarti d’ora i trolley imbarcati, molte mascherine si sono abbassate per stanchezza o dispnea, stiamo tutti attaccati al nastro per agguantare la valigia appena passa. Il problema è che il treno per Milano Cadorna, il penultimo secondo l’orario, parte alle 23 e 23, abbiamo comprato i biglietti dal sito già in Sicilia, per essere più veloci all’arrivo. Non lo vorremmo perdere e appena vediamo le valige uscire dal sottosuolo e cadere sul nastro trasportatore ci precipitiamo a prenderle e corriamo via, la strada per arrivare al treno non è breve. Francesco da sotto la mascherina continua a dirmi stai calma c’è tempo, teme per le mie aritmie.

All’ingresso della stazione siamo una decina, altre persone arrivano alla spicciolata, la stazione però è chiusa, non ci sono e non ci saranno treni fino a domani, l’ultimo è partito alle undici, incurante. Abbiamo comprato biglietti per un treno che non esiste. Non c’è nessuno a cui chiedere o contro cui inveire, eccezion fatta per un gruppo di famelici tassisti lombardi che presidia l’ingresso in attesa di prede. Sciura di treni non ce n’è, vi porto io a casa, cento euri e passa la paura, mi dice uno sarcastico e irritante. Con un moto d’orgoglio gli dico che non se ne parla neanche e mentre Francesco sarebbe disposto a contrattare mi consulto con la signora Lucia, catanese conosciuta sull’aereo, lei sostiene che non tutto è perduto, da qualche parte deve esserci un autobus che va alla stazione Centrale di Milano. Andiamo a cercarlo, su e giù per altissime scale mobili, ci perdiamo, arriviamo agli imbarchi dei voli internazionali, sembra che da lì non ci sia modo di tornare indietro, dalle vetrate si vede un cielo di fulmini e pioggia, vorrei dormire magari su una panca, aspettare che faccia giorno. Lucia trova un uomo gentile in divisa non identificata, ci riporta a piano terra e ci dice di provare all’uscita numero quattro.
Infatti c’è un autobus che sta partendo, va alla stazione Centrale di Milano. Il prossimo è a mezzanotte, manca poco e ci sono già parecchie persone che aspettano, quasi tutti giovani uomini, bangladesi, indiani, iraniani, afgani, africani, alcuni vestiti all’occidentale, altri con abiti lunghi, bianche tuniche, cappelli e turbanti. Parlano ad alta voce lingue ignote, molti senza mascherina. Pochissimi gli europei. Chissà, mi dico, per riuscire ad arrivare avranno triangolato da qualche posto autorizzato, avranno superato dei controlli, ma dove? L’aeroporto è deserto, non abbiamo incontrato nessuno che facesse controlli, forse per questo non sanno che le mascherine sono obbligatorie?
Mentre questi pensieri inquieti mi occupano la mente e cerco di prevedere le traiettorie intrecciate degli sputacchi vaporizzati prodotti dall’umanità vociante intorno a me, una prosperosa ragazza, incredibilmente vestita di lamé nonostante la situazione, la pioggia, i tuoni e i fulmini, mi chiede venti euro per i biglietti. L’autobus è arrivato, Lucia, Francesco e io saliamo tra i primi; ci scaglioneranno, mi dico, ci sarà un’altra corsa. E invece no, salgono tutti, l’unico posto libero è accanto a Lucia che si è quasi distesa con lo zaino addosso. La ragazza in lamé fa la conta dei paganti per verificare che non ci siano clandestini e partiamo.

Non dimenticherò facilmente il viaggio di un’ora, sotto la pioggia, tra Malpensa e Milano, l’ho fatto con una doppia mascherina, respirando piano, passando dal timore per la mescolanza all’imbarazzo per il timore della mescolanza. Su quell’autobus carico dei nostri odori di umanità umida di pioggia mi è sembrato di vedere svolazzare nella penombra le eleganti palline grigie e rosse con cui ho codificato nella mente l’immagine del Covid 19. Sono sicura che il virus c’era, anche se non ho prove e magari avevo respirato troppa anidride carbonica a causa della doppia mascherina.




