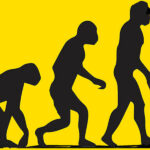di Robin Morgan
Illustrazione di Viola Gesmundo
Traduzione di Margherita Giacobino

I popoli indigeni rappresentano il 5% della popolazione mondiale e il 90% della diversità culturale del pianeta; hanno territori tradizionali che si estendono dal 20 al 30% della superficie terrestre e che a loro volta ospitano l’80% della biodiversità del pianeta. Eppure le popolazioni indigene sono troppo raramente incluse nei piani per la conservazione.
Ciononostante, la loro presenza persiste nel linguaggio, soprattutto nei nomi dei luoghi, in particolare, ma non certo in modo esclusivo, nella stessa New York. La filosofa Susanne K. Langer ha scritto: “La nozione di dare un nome a qualcosa è l’idea generativa di più ampia portata che sia mai stata concepita”. Ma l’assorbimento – l’appropriazione, la cannibalizzazione – è qualcosa di ben diverso. Un recente articolo di Joshua Jelly-Schapiro sul New Yorker mi ha fatto riflettere. Ha scritto che tra il 1492 e la rivoluzione americana del 1776, la popolazione indigena di questo continente è diminuita da una cifra stimata di 10 milioni a un decimo della stessa – e uno degli effetti meno noti del genocidio è stato quello linguistico. Preoccupata come sono dalle parole, l’ho già detto e scritto in passato: secondo i linguisti, nel XV secolo ben un quarto delle lingue della Terra erano americane – e quei milioni di parole sono andate perdute.
Eppure i cosiddetti “coloni” erano certamente disposti, se non desiderosi, di rubare quelle parole. A New York, la prima parola di questo tipo adottata dagli europei divenne la più famosa. Nell’autunno del 1609, qualche settimana dopo che Henry Hudson aveva iniziato l’esplorazione del grande fiume che in seguito avrebbe preso il suo nome, uno dei marinai di Hudson scrisse nel suo diario di bordo che la riva orientale boscosa del fiume era conosciuta dai nativi della zona come “Manna-hata”. Queste persone, che parlavano una lingua algonchina chiamata Munsee, avevano preceduto Hudson di circa mille anni. I loro antenati avevano lasciato la terraferma eurasiatica millenni prima, attraverso il ponte terrestre di Bering, e si erano spostati gradualmente nel continente per raggiungere il suo fertile margine orientale. Si erano stabiliti nei boschi pieni di cervi che circondavano una baia naturale le cui profondità brulicavano di pesci e i cui fondali erano popolati, all’inizio dell’era coloniale, da miliardi di ostriche. Negli anni successivi, queste persone – insieme ai loro cugini meridionali che parlavano una lingua algonchina affine ma distinta, chiamata Unami – vennero conosciute come Delaware, dal nome di un inglese.
Oggi, i discendenti di quei “Delaware” si riferiscono a se stessi con la parola che i loro antenati usavano per “essere umano”, Lenape. Non sappiamo per quale motivo i Lenape incontrati da Hudson chiamassero la riva orientale del fiume Manna-hata, perché Hudson rivendicò la loro casa per la Compagnia olandese delle Indie orientali e nel giro di tre secoli dal suo arrivo, la maggior parte dei Lenape era morta o si era dispersa nelle riserve dell’Ontario e dell’Oklahoma, dove sono rimasti molti dei loro discendenti.
In assenza dei Lenape, è stato lasciato ai filologi non nativi il compito di proporre teorie sull’etimologia di “Manhattan”. Negli ultimi decenni, nuove ricerche da parte di linguisti, attivisti e degli stessi Lenape hanno prodotto ulteriori teorie. La più accreditata è quella di Albert Anthony, uno studioso e parlante Munsee in Canada, che ha suggerito che Man-a-ha-tonh significhi “luogo in cui raccogliamo legname per archi e frecce”.
La superiorità numerica e le malattie contagiose riuscirono a spingere quasi tutti i Lenape (insieme agli Esopus, ai Wappinger e ai Mahican, tribù della Valle dell’Hudson), ad abbandonare le loro case ancestrali. Ma, prima che se ne andassero, non poche delle loro parole vennero ad abbellire la zona. Alcuni di questi nomi appartengono a sackem (capi tribù) che hanno lasciato il loro segno negli atti coloniali (Katonah, Kensico).
Ossining, nella contea di Westchester, può oggi ricordare le fiction di John Cheever o la prigione di Sing Sing; un tempo era una parola Munsee per “luogo pietroso”. A Long Island, diversi nomi di città sono presi in prestito da gruppi locali di Lenape (Massapequa, Matinecock) o dalle popolazioni di lingua Pequot, più a est (Manhasset, Montauket). Una tribù di lingua algonchina, gli Shinnecock, ha ottenuto il riconoscimento federale nel 2010. Ora hanno finalmente un pezzo degli Hamptons tutto loro e una riserva permanente.
Nell’antica patria dei Lenape lungo l’Hudson, vicino al paesaggio di paludi e centri commerciali di quelle che oggi sono le Meadowlands, non pochi nomi di luogo dei nativi designavano anche gruppi di persone: Passaic (“fiume che scorre in una valle”); Hackensack, (o “ruscello che si scarica in un altro sul terreno pianeggiante”); e Raritan (“punto di un fiume di marea”). Raritan è ancora oggi il nome del fiume più lungo del New Jersey e della baia in cui sfocia.
Walt Whitman era un grande appassionato di nomi indiani. Un esempio: “Mississippi! – la parola si snoda in cascate – è un torrente lungo tremila miglia”. Whitman non notò che l’espressione “Mississippi River” è ridondante: Mississippi infatti in algonchino Anishinaabe significa già “Grande Fiume”.
Non è l’unica cosa che non ha notato. Nell’arco della vita di Whitman ebbe luogo la rimozione forzata delle ultime tribù dell’Est lungo il Sentiero delle lacrime; il poeta scrisse molto sul tema dei popoli nativi e delle loro lingue, ma li ridusse con venerazione a una presenza spettrale, utilizzando il tropo razzista dell’indiano che scompare. In effetti, alla fine della vita di Whitman, gli americani avevano un pantheon di capi nativi martirizzati, il cui coraggio nella difesa del proprio popolo era evidentemente più facile da ammirare dopo averli sconfitti. I nomi di molti di questi capi – Pontiac, Tecumseh, Seattle – sono diventati città.
Nella città più grande d’America, la spinta a commemorare i vinti arrivò al punto che nel 1911 il Congresso fornì un terreno per costruire un Monumento Nazionale ai Nativi Americani (che fortunatamente non fu mai costruito). Un monumento che sarebbe stato tanto più offensivo in quanto si proponeva di commemorare, in sintonia con Whitman, quella che che veniva definita una “razza scomparsa” – collocando così i primi abitanti dell’America completamente nel passato della nazione. Un insulto a tutti i loro discendenti, che non sono affatto scomparsi, ma che vivono una vita moderna oscurata dalla violenza del passato.
Oggi, nella sola New York, la loro presenza è proclamata a gran voce nei powwow che ogni giugno portano i tamburini Mohawk e gli anziani Abenaki a Inwood Hill Park e ogni ottobre a Randall’s Island nell’East River, per cantare canzoni e mangiare frittelle. Ma la loro impronta è anche nei modi in cui i nativi americani hanno plasmato la New York di oggi. Molti dei grattacieli della città sono stati costruiti dai famosi “Mohawk in High Steel” (su alti ponteggi) che, a partire dagli anni Venti, si recarono in città dalle riserve del nord, portando con sé un’immunità collettiva alle vertigini che li rendeva i lavoratori ideali degli edifici più alti. Questi impavidi Mohawk hanno letteralmente creato la città. (In seguito, avrebbero creato un’enclave a Gowanus).
Negli ultimi anni, ruoli vitali nell’economia della città sono stati svolti da gente che arriva da settori ancora indigeni dell’emisfero: parlanti di Aymara e Quechua, dalle Ande; di Mixtec e Maya, dal Messico; di Tzotzil e K’iche’, dal Guatemala. Non meno importante è stato il ritorno alla visibilità del primo popolo di New York.
Dal 2008, il Lenape Center di Manhattan ha mantenuto un ufficio attivo, sotto l’egida della New York Foundation for the Arts, nel cuore di quello che i suoi direttori chiamano Lenapehoking: la patria dei Lenape. Nel 2016, il figlio di un ricco artista del Greenwich Village – in realtà il West Village, ovvero la parte di Manhattan che i Lenape chiamavano Sapokanikan, o “campo di tabacco” – ha donato alla tribù una sede da quattro milioni di dollari.
New York può non essere un luogo che la maggior parte delle persone associa agli amerindi, ma ne comprende oltre centomila, secondo l’ultimo censimento, ovvero più di qualsiasi altra città degli Stati Uniti. Il che mi rende, ancora una volta, orgogliosa di essere newyorkese!
*L’articolo è apparso sul blog di Robin Morgan il 5 giugno 2023