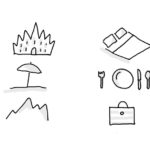di Robin Morgan
Traduzione di Margherita Giacobino
Le città del mio paese stanno di nuovo bruciando. Di nuovo uomini bianchi armati in uniformi blu hanno di nuovo impedito a un uomo nero di nuovo disarmato e senza uniforme di respirare. Intanto, là nelle Grandi Pianure e nella Cintura del Grano altra gente muore in modo diverso, con il virus che gli cresce nei polmoni, mentre febbricitanti addetti all’imballaggio carni devono presentarsi al lavoro per non far morire di fame le loro famiglie, mentre contadini si mettono a letto con la tosse e il fiato corto perché mancano le apparecchiature per tenerli in vita. Nei piccoli centri e nelle fabbriche altri sono caduti per la bugia che tutto ciò fosse una truffa, colpa della gente di colore e di quelli delle città; adesso anche loro non respirano più.
I colpi arrivano così veloci e pesanti che non ti sei ancora rialzata barcollando dall’ultimo che un altro ti risbatte giù senza fiato di nuovo. L’impresa privata si lancia nello spazio, le economie nazionali crollano – ehi, questo è il meno. Ondate di calore sciolgono il Sudest Asiatico, mandano arrosto l’Europa; incendi boschivi devastano l’ovest degli Stati Uniti e l’Australia; il Sudamerica è assetato per l’emergenza-acqua; in Africa il fetore si diffonde nell’aria quando sciami di cavallette di densità record trasformano ripetutamente il giorno in notte. In India un ciclone si abbatte su Calcutta, nel Midwest USA due dighe si schiantano sotto l’impeto delle piogge, violentissimi uragani sono previsti sull’Atlantico nella prossima stagione. Durante il lockdown abbiamo elogiato la drastica riduzione dei gas serra: adesso sappiamo che ci vorrebbe ben altro per allentare la densa coltre di gas che soffoca la terra. I casi di asma ed enfisema sono in aumento. Respirare diventa più difficile. Il livello delle acque sale, ondate di tempesta abbattono gli argini, annegano le risaie, allagano i campi.
Generazioni di contadini e pescatori in sei continenti migravano verso le città per lavorare, ma il lockdown li ha fermati.
Sono vecchie novità, vero? Predette da decenni, anzi da un secolo o due. Ma la scienza è stata ignorata o messa da parte e gli scienziati derisi come Cassandre distopiche. La pandemia, che (finora) ha ucciso globalmente quasi mezzo milione di persone è stata generata da un pianeta febbrile il cui catastrofico riscaldamento minaccia milioni di altri umani. Per non parlare delle specie spinte all’estinzione. La morte è una cosa. La fine delle nascite è un’altra.
Cosa non era stata predetto? L’accelerazione. All’improvviso: un angolo svoltato, parole dette che non possono essere rimangiate, e scivola slitta va in frantumi ciò che sarebbe dovuto durare fino alla fine del secolo almeno fino a quando non avessimo pensato soluzioni creative. Ma come fai a pensare a qualcosa a questa velocità e quando non riesci a respirare?
E non c’era modo per nessuno di prepararsi allo shock dell’enormità. Così tanto, mio dio troppo, troppo su tutti i fronti basta con questa valanga che non si ferma mai neppure un secondo per farti riprendere fiato, questo flusso di lava che acquista sempre più massa insieme alla velocità, questa bufera di notizie tetra come le migliaia di bugie che escono ronzando dalla bocca di una creatura che si aggira demente per tutta la notte sui tappeti rossi del potere della Casa Bianca. Così tante bugie, troppe per riderne, ribattere, tenere il conto, sbarazzarsene. Il segreto è il volume, l’entità pura e semplice è difficile da credere, un eccesso in cui ci dibattiamo, annegandoci dentro finché quasi non sappiamo più dove finiamo noi e comincia lui: il vomito di una speranza andata a male che soffoca l’urlo, strozza il grido in gola, imbavaglia l’imprecazione, spegne le memorie di una democrazia. L’eccesso era già ritenuto normale, è ciò a cui certuni desiderano tornare. Terra di abbondanza avidità voglio voglio voglio discount occasioni dis-mis-informazione sempre più più più click valutazioni follower amici jumbo negazione all-you-can-eat odio maxisvendita di paura overstock di stupidità dammi fuori-tutto dammi dammi bugie king-size. Troppe scelte e sempre meno scelta. Un’abbondanza di mancanza. Mancanza di fatti, lucidità, ossigeno, tempo.
Ora bruciano più città. Cittadini neri che rifiutano il massacro, corpi neri sparati e bastonati per il peccato di essere sopravvissuti alla condizione di schiavi, spiriti di neri e polmoni di neri soffocati che muoiono ancora e ancora implorando Per favore non riesco a respirare. Eric Garner sei anni fa a New York: “Non riesco a respirare”. George Floyd, sei giorni fa, a Minneapolis. La stretta che soffoca, le stesse ultime parole. Così tante volte, così tanti uomini, tante definizioni di virilità in gioco, così tanta morte. Le donne non vengono risparmiate, soltanto meno notate perché sono solo femmine e perché la morte le abbatte là dove se ne stanno, tranquille, a casa, senza minacciare nessuno mostrando l’impudenza di camminare per le vie della loro stessa città. Alberta Spruill, Rekia Boyd, Shantel Davis, Shelley Frey, Kayla Moore, Kyam Livingstone, Miriam Carrie, Michele Cusseaux, Tanisha Anderson – sì, dite i loro nomi. Come se dire i loro nomi potesse riportarle in vita. Ma dire i loro nomi le rende di nuovo reali, non le lascia sparire, almeno per un momento. Breonna Taylor, appena il marzo scorso: una giovane, bella ed esperta tecnica medica che dopo un’altra dura giornata in cui era andata a prendere pazienti malati di Covid-19 rischiando la vita, la notte dormiva con il suo ragazzo nella sua camera da letto quando poliziotti in borghese hanno sfondato la porta e sparato otto pallottole nel suo corpo minuto. Quanti altri nomi, troppi, una lista così lunga che i dettagli unici preziosi di ogni vita individuale e insostituibile vanno persi, resta solo un altro nome che svanisce nei numeri, si perde nello sforzo di ricordare chi quando come è stata uccisa come dove perché è stato ucciso quando finisce tutto questo come mettiamo fine a tutto ciò siamo tutti umani facciamo errori certo ma fare lo stesso errore ancora e ancora non è più un errore come rifiutarsi di ingoiarlo come vomitarlo ci stiamo mettendo troppo a imparare come.
Non metto in mostra la mia disperazione in questo spazio. Questo spazio è per confortare, informare, essere utile. Io qui scrivo in prosa. La prosa è il linguaggio dei fatti, la legge, i rapporti, la lista della spesa, lettere, discorsi, appunti buttati giù sul comodino dopo quell’incubo che non vorresti ricordare ma meglio non dimenticarlo. La poesia è il linguaggio della verità. La poesia, un reattore nucleare, è stata costruita forte abbastanza da contenere l’energia della desolazione, afferrare il potere di questa energia, incanalarlo, farlo girare. La prosa è il linguaggio della vendetta. La prosa firma ordini esecutivi, lancia comunicati stampa e mattoni nelle vetrine. La prosa è brillante nel ragionare, tosta nel mobilitare, nel portare avanti. Anche la poesia fa tutto questo, le basta schioccare le dita – ma porta anche una teglia di stufato in casa della madre della donna morta, lascia una rosa sul marciapiedi nel punto in cui l’uomo morto è stato colpito. La prosa incita la rabbia, invoca la pace, forma comitati, auspica il cambiamento, approva leggi, a volte ne applica perfino qualcuna. La poesia identifica il corpo. La poesia richiude le palpebre e tira su la cerniera sopra il viso.
La poesia è dove sono libera di sanguinare. Allora qui il mezzo è la prosa, dato che il mio dolore non cambia niente. Al pianeta resta poco tempo, a me ancora meno, la mia pelle è ancora sempre bianca, e i miei attrezzi sono ancora solo queste parole. Ma domani il lutto ci richiede di alzarci in piedi e rivestiti della nostra migliore disperazione trascinarci avanti, un passo alla volta, a testa alta, come se fossimo invincibili, facendo quello che possiamo un centimetro dopo l’altro finché la nostra parte non è finita.
Perdonatemi per avervi fatto sbirciare quest’ora desolata – anche se chi osa dire che tu o io non abbiamo diritto alla disperazione?
Alla prosa vanno la mia gratitudine e il mio rispetto per aver liberato queste parole dalla stretta che soffoca, lasciandole respirare, permettendomi di reclamarle, di lasciarle andare e di riconoscere il loro passaggio.
La poesia siede accanto alla bara e piange.
(Il testo è uscito il 1 giugno 2020 sul blog di Robin Morgan, poeta, scrittrice, attivista statunitense. Ringraziamo l’autrice per averci gentilmente concesso di riprenderlo.)