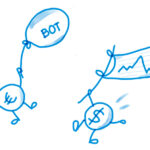di Robin Morgan
Illustrazioni di Isia Osuchowska
Traduzione di Margherita Giacobino

Torno su un tema già affrontato, in particolare in Cuore di bianchezza, per parlarne in relazione alla teoria critica della razza, demonizzata dai suoi oppositori che sostengono, in modo del tutto infondato, che la si insegna perfino ai bambini dell’asilo.
La teoria critica della razza è in realtà una storia della bianchezza, che è diversa dalle altre identità razziali e dalle relative storie. Come ha sottolineato Robert P. Baird qualche anno fa sul Guardian, “per tre secoli e mezzo la bianchezza è stata brandita come un’arma su scala globale; la nerezza, al contrario, è stata spesso usata come uno scudo”. (Come disse W.E.B. DuBois, ciò che rendeva la bianchezza nuova e diversa era “la vastità imperiale della faccenda – la sua audacia smisurata”).
Come ha sottolineato Baird, è abbastanza facile concordare in teoria sul fatto che l’unica risposta morale ragionevole alla storia della supremazia bianca sia la posizione abolizionista, ossia rendere la bianchezza priva di significato come identità di gruppo, gettarla nell’obsolescenza come l’identità “prussiana” o “etrusca”. James Baldwin ha definito la bianchezza una scelta morale, per sottolineare che non è un fatto naturale. Ma la bianchezza è molto più di questo: è una fitta rete di scelte morali, la maggior parte delle quali è stata fatta per noi, spesso in tempi e luoghi molto lontani. In effetti, la bianchezza è un problema come il sessismo, il cambiamento climatico o le disuguaglianze economiche: è così profondamente radicata nella struttura della nostra vita quotidiana da far sembrare bizzarra l’idea delle scelte morali.
Eppure l’identità bianca è un mito assoluto, una fantasia, una finzione.
La scienza lo chiarisce una volta per tutte: leggete Il lungo viaggio dell’uomo, l’odissea della specie, di Spencer Wells, e capirete che si tratta semplicemente della quantità di vitamina D presente nel corpo, che la melanina può assorbire e che determina la pigmentazione della pelle. Tutto lì.

In generale, i sondaggi hanno rilevato che l’attenzione per le questioni razziali, in sé un cambiamento importante nell’atteggiamento dei bianchi statunitensi, non ha portato a politiche che migliorino le disuguaglianze razziali. D’altra parte, questa nuova attenzione alla razza ha generato confusione tra i bianchi, non abituati a pensare a se stessi in termini razziali, perché si ritengono il generico. La metà dei bianchi USA pensa che si parli “troppo” di questioni razziali e più o meno altrettanti suggeriscono che vedere il razzismo dove non esiste è un problema più grande che non vedere il razzismo dove esiste. Eppure, quasi ovunque nella società contemporanea il termine “bianco” è visto come un indice significativo di identità, come l’età e il sesso, un elemento abbastanza importante da essere menzionato nelle notizie, nei resoconti, nei sondaggi politici e registrato nei database governativi. Tuttavia, ciò che questa identità rappresenterebbe è ancora sostanzialmente in discussione. La bianchezza assomiglia al tempo, come lo definisce Sant’Agostino: siamo convinti di capirlo finché non ci viene chiesto di spiegarlo, ma diventa inspiegabile non appena ci proviamo.
Poco più di un secolo fa, nel suo saggio “The Souls of White Folk”, W.E.B. Du Bois propose un’intuizione importante: la scoperta della bianchezza personale tra i popoli del mondo è un fatto molto moderno, che riguarda la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento, e la categoria razziale della bianchezza è più simile a una credenza religiosa che a un dato biologico.
Con una leggera esagerazione, possiamo dire che uno degli sviluppi più cruciali nella scoperta della “bianchezza personale” ebbe luogo nella seconda metà del Seicento, alla periferia dell’ancora giovane impero britannico. Gli storici hanno ampiamente confermato i sospetti di Du Bois, secondo cui il primo inventore di un’identità razziale bianca fu Eric Williams, che in seguito divenne il primo ministro di Trinidad e Tobago; in altre parole, “la schiavitù non nacque dal razzismo: piuttosto, il razzismo fu la conseguenza della schiavitù”.
Qui vi fu una sovrapposizione, determinante, con la religiosità, in particolare con il cristianesimo.
La bianchezza divenne la parola d’ordine della purezza (in particolare per le donne bianche). Questa sovrapposizione religiosa si trasformò presto in una sovrapposizione legale, con le leggi coloniali che concedevano privilegi speciali ai cristiani che, in quanto autori delle leggi, apparentemente non avevano mai preso in considerazione la possibilità che gli africani potessero un giorno desiderare di diventare cristiani a loro volta. L’idea di bianchezza aveva poi un’indubbia utilità economica, che l’aiutò a diffondersi rapidamente in tutto il mondo. Si trattava realmente di una religione, dal momento che, come ogni religione, operava a livello psicologico, sociologico, economico e politico, dalla sfera più intima alla più pubblica. Inoltre, si dimostrò meravigliosamente adattabile alle condizioni locali! Essere bianco nella Virginia britannica non significava la stessa cosa che esserlo a New York prima della guerra civile americana, o in India durante l’impero britannico, o in Georgia nel periodo delle leggi Jim Crow, o in Australia dopo la federazione o in Germania durante il Terzo Reich. Ma un elemento era comune: il gruppo di persone definito bianco era naturalmente superiore a tutti gli altri.
L’idea di bianchezza, in altre parole, coincideva con l’idea di supremazia bianca. E contagiò tutti. Persino Gandhi, da giovane, sostenne che “gli inglesi e gli indiani derivano da un ceppo comune, chiamato indo-ariano, e la razza bianca in Sudafrica dovrebbe essere la vera razza dominante”.
Per di più, la supremazia bianca – l’idea di bianchezza – era una festa mobile. Da un lato, c’era la logica insensata che sosteneva che chiunque avesse antenati neri non poteva essere bianco e stabiliva i confini della bianchezza: negli Stati Uniti, per esempio, bastava una sola goccia per non esserlo. Ci sono state discussioni infinite sul significato di “caucasico”, sullo status di “ariano onorario” esteso da Hitler ai giapponesi e così via. Tuttavia, se la religione della bianchezza non è mai stata in grado di affermarsi come un fatto scientifico incontestabile, ha avuto un’ enorme efficacia nel plasmare la realtà sociale. Nel 1751, Ben Franklin poteva affermare che solo gli inglesi e i sassoni “costituiscono il corpo principale dei bianchi sulla faccia della Terra”, e quasi 80 anni dopo Ralph Waldo Emerson avrebbe insistito sul fatto che gli irlandesi, come i cinesi e i nativi americani, non erano caucasici. Col tempo però la definizione di chi si poteva considerare culturalmente bianco si estese fino a includere i cattolici dell’Europa meridionale, gli irlandesi e persino gli ebrei, che per secoli erano stati visti come la quintessenza degli outsider. La e bianchezza era quindi una categoria in espansione, e nel frattempo rafforzava il suo potere e imponeva i suoi privilegi attraverso leggi, istituzioni, costumi e chiese. Non solo: ricorreva alla minaccia della forza e alla forza stessa, con la quasi totale estinzione delle popolazioni indigene del Nord America, le atrocità belghe in Congo, la sanguinosa colonizzazione dell’India, dell’Africa orientale e dell’Australia da parte della Gran Bretagna, l’altrettanto sanguinosa colonizzazione del Nord Africa, dell’Africa occidentale e del Sud-Est asiatico da parte della Francia, il dispiegamento della soluzione finale nella Germania nazista e lo Stato dell’apartheid in Sud Africa – e questi sono solo gli esempi più estremi.
Negli anni ’80 e ’90, un gruppo di studiosi di diritto che comprendeva Derek Bell, Kimberlé Crenshaw, Cheryl Harris e Richard Delgado ha prodotto un corpo di ricerche che è diventato noto come teoria critica della razza, che, nelle parole di Bells, era “ideologicamente impegnata nella lotta contro il razzismo, in particolare quello istituzionalizzato nella e dalla legge”. Parallelamente alla teoria critica della razza, e per molti versi da essa derivati, presero forma i “Whiteness Studies”: gli storici che lavoravano in questo sottocampo dimostrarono la miriade di modi in cui la ricerca della supremazia bianca, come la ricerca della ricchezza e l’assoggettamento delle donne, era stata una delle forze centrali che avevano plasmato la storia angloamericana. Ma a metà degli anni Duemila il sistema ideologico del “color blind”[1] aveva preso talmente piede da riuscire a mettere al riparo dalla censura anche le più sfacciate operazioni di bianchezza: il numero schiacciante di persone bianche nei consigli di amministrazione delle aziende, per esempio, o nei media, o nelle industrie tecnologiche. E la bianchezza è anche riuscita a sfuggire alle previsioni di catastrofe demografica integrando gruppi selezionati che prima teneva ai margini.
La verità è che non abbiamo bisogno di diventare “color blind”, ma abbiamo un disperato bisogno di diventare “alfabetizzati nel colore”. La bianchezza può sembrare inevitabile e implacabile, e Toni Morrison aveva ragione quando diceva che “non basta affermarlo per far sì che il mondo si liberi dall’idea di razza.”
Con tutto ciò, dopo 350 anni, la bianchezza è ancora solo un’idea, non un fatto. Sta a noi trasformare quell’idea, e il cambiamento deve iniziare dall’idea di noi stessi.
- “Color blind”, letteralmente “cieco al colore” è chi ritiene che il colore non debba influenzare il modo in cui un individuo viene trattato, che deve invece basarsi solo sul merito. Un’ideologia di uguaglianza che rifiuta le azioni a sostegno dei meno privilegiati e che, applicata in una società tutt’altro che egualitaria, può nascondere o ribadire il razzismo e il classismo invece di eliminarli.
*L’articolo è apparso sul blog di Robin Morgan il 13 febbraio 2022